Se certa letteratura del 900 ha attinto alla psicanalisi per
raccontare la complessità della psiche e dare vita a personaggi come Zeno
Cosini de La coscienza di Zeno o Moscarda in Uno, nessuno e centomila, è anche vero che il tema
dell’identità ha affascinato la letteratura di tutti i tempi.
In
tempi non sospetti, Plauto, tra il III e il II sec a. c. scriveva l’Anfitrione,
una commedia esilarante in cui per la prima volta nella storia della
letteratura veniva affrontato il tema dell’identità e del doppio.
Nella
vicenda, che è tratta dal mito, agiscono insieme uomini e divinità. Il personaggio
principale, Anfitrione, parte per la guerra lasciando sola la moglie Alcmena.
Giove, che è innamorato di lei, assume le sembianze di Anfitrione per poter
trascorrere con lei una notte d’amore e incarica Mercurio, che a sua volta ha assunto le sembianze di Sosia -il servo di Anfitrione-, di sorvegliare
la casa dall’esterno.Intanto, conclusasi la guerra, Anfitrione (quello
vero) s’appresta a far ritorno a casa e incarica Sosia (quello
vero) di recare la bella notizia ad Alcmena. Al suo arrivo, Sosia
s’imbatte nell’altro Sosia -Mercurio sotto mentite spoglie- e al vedere
quell’altro se stesso, è così confuso che arriva a dubitare di sé, non sa più
chi è, non capisce chi dei due è il vero Sosia.
Se certa letteratura del 900 ha attinto alla psicanalisi per raccontare la complessità della psiche e dare vita a personaggi come Zeno Cosini de La coscienza di Zeno o Moscarda in Uno, nessuno e centomila, è anche vero che il tema dell’identità ha affascinato la letteratura di tutti i tempi.
In
tempi non sospetti, Plauto, tra il III e il II sec a. c. scriveva l’Anfitrione,
una commedia esilarante in cui per la prima volta nella storia della
letteratura veniva affrontato il tema dell’identità e del doppio.
Nella
vicenda, che è tratta dal mito, agiscono insieme uomini e divinità. Il personaggio
principale, Anfitrione, parte per la guerra lasciando sola la moglie Alcmena.
Giove, che è innamorato di lei, assume le sembianze di Anfitrione per poter
trascorrere con lei una notte d’amore e incarica Mercurio, che a sua volta ha assunto le sembianze di Sosia -il servo di Anfitrione-, di sorvegliare
la casa dall’esterno.Intanto, conclusasi la guerra, Anfitrione (quello
vero) s’appresta a far ritorno a casa e incarica Sosia (quello
vero) di recare la bella notizia ad Alcmena. Al suo arrivo, Sosia
s’imbatte nell’altro Sosia -Mercurio sotto mentite spoglie- e al vedere
quell’altro se stesso, è così confuso che arriva a dubitare di sé, non sa più
chi è, non capisce chi dei due è il vero Sosia.
MERCURIO
Tu
oggi non mi impedirai mai di essere Sosia.
SOSIA
E tu
non mi impedirai di essere io. Sì, qui di Sosia ce n'è uno solo, e sono io. Io,
che me ne sono andato alla guerra con Anfitrione.
MERCURIO
Quest'uomo
è malato nella testa.
SOSIA
Malato
sarai tu. Accidenti, non sono io Sosia, il servo di Anfitrione? Non
è
arrivata qui, stanotte, dal porto Persico, la nostra nave, che mi ha
trasportato?
Non mi ha mandato qui il mio padrone? E adesso non sono qui
davanti
alla nostra casa? Non ho in mano una lanterna? Non parlo? Non sono
sveglio?
Quest'uomo non mi ha pestato poco fa? Mi ha picchiato, accidenti,
e le
mascelle mi fanno ancora male, povero me. E allora perché dovrei
avere
dei dubbi? E perché non entro in casa nostra?
MERCURIO
Come?
Casa vostra?
SOSIA
Proprio
così.
MERCURIO
Frottole. Tu hai raccontato un
sacco di frottole. Sono io il Sosia di Anfitrione. Io. La nostra nave è salpata
stanotte dal porto Persico, abbiamo espugnato la città sulla quale Ptérela
regnava, abbiamo catturato, con la forza delle armi, le legioni
dei Teleboi, Anfitrione in persona ha mozzato la testa di Ptérela nel vivo
della battaglia.
SOSIA
Non
credo alle mie orecchie, quando gli sento dire queste cose. Non c'è dubbio, ricorda tutto, e racconta bene. Ma tu
dimmi una cosa: ad Anfitrione, cosa gli hanno regalato i Teleboi?
MERCURIO
La
coppa d'oro da cui era solito bere il re Ptérela.
SOSIA
L'ha
detto. E dov'è adesso la coppa?
MERCURIO
In un
cofanetto, che reca il sigillo di Anfitrione.
SOSIA
E il
sigillo com'è?
MERCURIO
Sole
levante con quadriga. Ma tu vuoi prendermi in castagna, razza di boia? SOSIA
Mi frega, con le sue risposte…..
MERCURIO
E adesso? L'ho dimostrato o no che non sei
Sosia?
Tu dici che io non sono io?
E come potrei non dirlo, se Sosia sono io?
SOSIA
Giuro su Giove che io sono io e non dico il
falso.
MERCURIO
E io giuro su Mercurio che Giove non ti crede.
Si fida più di me che dei
tuoi giuramenti, anche se io non giuro.
SOSIA
E io, allora, chi sono, se non sono Sosia?
Te lo domando.
Quando non vorrò più essere Sosia, siilo
pure tu. Ma mentre lo sono io, tu
……………….
SOSIA
Meglio tagliare la corda. Dèi immortali, vi
prego: dov'è che sono morto?
Plauto, Anfitrione, Atto ILa
comicità del dialogo è irresistibile,
ma l’argomento è serio e pone diverse questioni: il riconoscimento di sé nella
propria specificità passa attraverso il riconoscimento della diversità
dell’altro; se non si è in grado o non si ha volontà di percepire l’altro (con la sua
storia, le sue esigenze, il suo vissuto) come altro da sé
e in lui si vede -o si vuole vedere- il proprio doppione, si finisce per ripiegarsi
narcisisticamente su se stessi, tagliando qualunque possibilità di
dialogo-confronto con l'esterno; il che non è cosa di poco conto, considerando
che solo misurandosi con l'altro è possibile crescere e acquisire esperienza del mondo.
Lo strano caso del dottor Jekyll e il signor Hyde, R. L. Stevenson

Il
vero capolavoro sul doppio è il romanzo 800esco Lo
strano caso del dottor Jekyll e il signor Hyde, opera di R.
L. Stevenson.
Quando Jekyll
sperimenta su di sé la pozione, il male prende possesso di lui, la
parte malvagia prevale sull’altra e il rispettabile-onesto Jekyll diventa il
violento Hyde, un individuo privo di scrupoli capace dei più efferati delitti.
Il tema è qui il doppio che ciascuno ha in sé: l’individuo è
in realtà un dividuo, poiché è scisso, diviso a metà
tra una cosa e il suo opposto, tra bene e male, egoismo e altruismo; il punto è
riuscire a trovare l’equilibrio giusto per non soccombere sotto il peso
dell’una o dell’altra parte.
Il visconte dimezzato, Italo Calvino
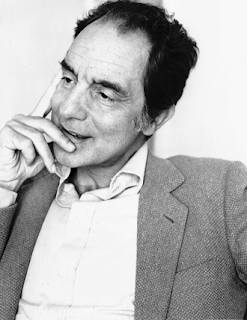
Italo Calvino
Italo
Calvino affronterà la tematica del doppio ne Il visconte dimezzato (1951).
Il
romanzo è la storia del visconte Medardo di Terralba. che, combattendo in
guerra contro i Turchi, è diviso esattamente a metà da una palla di cannone: la
parte buona sembra perduta chissà dove, rimane solo la metà cattiva, con grande
disappunto degli abitanti di tutta la città di Terralba, che devono subire la
sua crudeltà.
Quando anche la parte buona ricompare, la situazione a
Terralba peggiora ulteriormente, perché il Medardo buono è noioso e
stucchevole, insopportabile come l’altro ma per motivi opposti. Le due metà non
si sopportano e arrivano a scontarsi in duello: il Buono e il
Cattivo (il Gramo) rimangono entrambi feriti, ma un intervento
chirurgico li salverà, le due parti verranno ricucite, Medardo recupererà la
sua interezza e Terralba ritroverà la serenità.
Dunque, se per Stevenson il
problema nasce dal conflitto tra bene e male che convivono nello stesso
individuo, la conclusione alla quale perviene Calvino è che al contrario l’uomo nella sua interezza è un miscuglio di bene e male, un'armonica combinazione tra opposti ed è giusto che sia così…
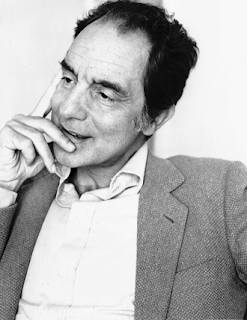
Il romanzo è la storia del visconte Medardo di Terralba. che, combattendo in guerra contro i Turchi, è diviso esattamente a metà da una palla di cannone: la parte buona sembra perduta chissà dove, rimane solo la metà cattiva, con grande disappunto degli abitanti di tutta la città di Terralba, che devono subire la sua crudeltà.
E così Medardo ritornò un uomo intero, né cattivo, né
buono, un miscuglio di cattiveria e di bontà, com'era prima d'esser dimezzato.
Ebbe vita felice, molti figli e un giusto governo….Forse ci s'aspettava che,
tornato intero il Visconte, s'aprisse un'epoca di felicità meravigliosa; ma è
chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il
mondo
E così Medardo ritornò un uomo intero, né cattivo, né
buono, un miscuglio di cattiveria e di bontà, com'era prima d'esser dimezzato.
Ebbe vita felice, molti figli e un giusto governo….Forse ci s'aspettava che,
tornato intero il Visconte, s'aprisse un'epoca di felicità meravigliosa; ma è
chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il
mondo
La metamorfosi, F. Kafka

Nel
1915 (quindi molti anni prima de Il visconte
La
metamorfosi è la storia di Gregor Samsa, un impiegato ligio e puntuale, che una
mattina, al risveglio, si ritrova trasformato in insetto, una sorta di
scarafaggio gigantesco.
Nel
tentativo di alzarsi dal letto, cade malamente sul fianco e si ferisce: quel
corpo nuovo si muove in maniera diversa dal solito, Gregor non riesce a
controllarlo.
Quando
finalmente riesce ad aprire la porta della sua camera afferrando con la bocca
la maniglia e facendola ruotare, i genitori e la sorella inorridiscono alla
vista di quell’essere mostruoso. Da questo istante Gregor vivrà recluso in
camera, lontano dai familiari che non nascondono il loro disgusto, accudito
solo dalla sorella che gli porta da mangiare gli avanzi.
Un
giorno Gregor esce dalla propria camera, disattendendo il divieto di farlo e il
padre, infuriato, lo colpisce con una mela, procurandogli una ferita che s’infetterà
causando qualche tempo dopo la morte di Gregor.
Nella sua metamorfosi in insetto, in un Gregor che è altro da sé ,
egli continua a pensare come prima, ha gli stessi sentimenti e le stesse
emozioni di sempre, è ancora umano ma non lo è più nell’aspetto, nel suo
rapporto con gli altri e con il mondo, e per questa sua diversità in mondo non
lo accoglie.
Il
riferimento autobiografico è indubbio: a leggere Lettera al padre,
si comprende tutta la conflittualità del rapporto tra F. Kafka e il padre, uomo
austero e severo, impietoso nel giudicare il figlio una sorta di invertebrato dalla
personalità troppo debole e arrendevole; d’altro canto,
nella stessa lunga lettera Kafka esprime più volte il proprio rammarico per non
riuscire ad essere come il padre lo vorrebbe, ma difende con fermezza le
proprie scelte, rivendica il diritto alla propria fragilità. L’insetto-Gregor,
il suo doppio, è simbolicamente l’alienazione di chi avverte
su di sé il peso di dover corrispondere alle aspettative e al contempo vive il
senso di colpa per non essere fino in fondo in grado di rinunciare ad essere se
stesso.
Voler
essere se stessi e al contempo desiderare di riuscire ad essere diversi: un lacerante conflitto interiore che genera mostri.

Nel
1915 (quindi molti anni prima de Il visconte
La metamorfosi è la storia di Gregor Samsa, un impiegato ligio e puntuale, che una mattina, al risveglio, si ritrova trasformato in insetto, una sorta di scarafaggio gigantesco.

Nessun commento:
Posta un commento
Posta un commento
Se vuoi contattarmi, scrivi a:
rita.filidoro@gmail.com